
 di ANDREA MASSARONI. La terra tremava ancora, con ripetute scosse di assestamento, dopo la notte di morte del 24 agosto, quando le prime interviste degli abitanti sopravvissuti hanno cominciato a girare sui media, seguite a ruota dalle dichiarazioni dei rappresentanti di governo (come il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio) e parlamento (come Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati): «Vogliamo ricostruire, non ce ne andiamo». L’affastellarsi di dichiarazioni, dai cittadini tra i calcinacci e i detriti di Amatrice o Accumoli e dai «camei» di solidarietà ai quali le autorità non possono sfuggire, è stato coerente e il sottotraccia chiaro: «Per elaborare il nostro lutto abbiamo bisogno di tornare a casa e fare in modo di riconquistare la familiarità nei luoghi e nelle abitudini». Io da qui non mi muovo.
di ANDREA MASSARONI. La terra tremava ancora, con ripetute scosse di assestamento, dopo la notte di morte del 24 agosto, quando le prime interviste degli abitanti sopravvissuti hanno cominciato a girare sui media, seguite a ruota dalle dichiarazioni dei rappresentanti di governo (come il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio) e parlamento (come Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati): «Vogliamo ricostruire, non ce ne andiamo». L’affastellarsi di dichiarazioni, dai cittadini tra i calcinacci e i detriti di Amatrice o Accumoli e dai «camei» di solidarietà ai quali le autorità non possono sfuggire, è stato coerente e il sottotraccia chiaro: «Per elaborare il nostro lutto abbiamo bisogno di tornare a casa e fare in modo di riconquistare la familiarità nei luoghi e nelle abitudini». Io da qui non mi muovo.
C’erano state polemiche in passato, quando a seguito del terremoto dell’Aquila, il Governo Berlusconi aveva proposto di costruire una «new town», seppure anch’essa provvisoria. E alle polemiche sono seguiti gli scandali e le proteste. In questa sede si vuole tralasciare la questione fattuale dell’opportunità, dei vantaggi e degli svantaggi dei vari approcci al ritorno alla vita, personale e delle comunità, dopo il sisma, per porsi un interrogativo di fondo: questa imperativa richiesta di restaurazione è qualcosa di universale o c’è in essa una tipicità italiana?
Intendiamoci, chi vede la propria casa o la propria attività distrutta, in qualunque Paese, desidera vederla di nuovo sana e funzionale. Questo è ovviamente umano. Ma l’assenza di un dibattito pubblico sull’opportunità di ricostruire in zone sismiche, pur consapevoli della storica incapacità al rigoroso rispetto delle più stringenti norme antisismiche, potrebbe avere una tipicità italiana.
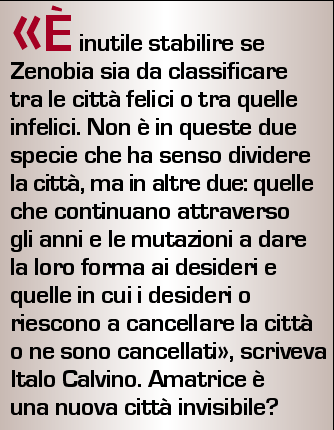 «Non potrei vivere altrove, qui sono cresciuto» è – a rigor di logica – una inferenza piuttosto zoppicante. L’identità personale e collettiva pare impossibile senza la conservazione dell’eredità del passato. Benedetto Croce aveva già detto che il «carattere», ovvero l’identità di un popolo è «la sua storia, tutta la sua storia, nient’altro che la sua storia». In una nazione con il patrimonio artistico, archeologico e culturale tanto vasto, questa affermazione appare tanto più cogente. E quando il racconto autobiografico – io sono il mio passato – diventa autorappresentazione collettiva, segna le scelte della comunità civile, politica e persino economica.
«Non potrei vivere altrove, qui sono cresciuto» è – a rigor di logica – una inferenza piuttosto zoppicante. L’identità personale e collettiva pare impossibile senza la conservazione dell’eredità del passato. Benedetto Croce aveva già detto che il «carattere», ovvero l’identità di un popolo è «la sua storia, tutta la sua storia, nient’altro che la sua storia». In una nazione con il patrimonio artistico, archeologico e culturale tanto vasto, questa affermazione appare tanto più cogente. E quando il racconto autobiografico – io sono il mio passato – diventa autorappresentazione collettiva, segna le scelte della comunità civile, politica e persino economica.
Non a caso l’Italia è il Paese della rendita: anche nell’economia il valore viene dal passato e se per tutelare la rendita si inibisce ogni altro tipo di crescita, poco male. O per dirla in terminologia cattolica, non è un gran peccato. Per questo si può dire che il nostro Paese è intrinsecamente conservatore. Il potere coincide con l’amministrazione del valore ricevuto, il potere è dei sacerdoti del tempio.

Foto di ROMINA CIUFFA
A ben guardare, anche i movimenti che nascono cercando una discontinuità vogliono farsi riconoscere come anti-sistema o cercano presto una legittimazione «storica»: pensiamo, ad esempio, ai fantasiosi riti «celtici» della Lega. Quando la legittimazione storica non c’è, la si può sempre inventare: la storia è piena di esempi in cui la narrazione si piega ad interessi contingenti. Questo riflesso condizionato in Italia è pervasivo e agisce a più livelli. Anche il cinismo di fronte alle novità – i nuovi ricchi, i nuovi «famosi», i nuovi leader – è effetto della devozione a ciò che viene ereditato.
Una devozione che può avere tratti masochistici e che produce grandi rimozioni. Ad esempio, fa tralasciare che farsi custodi zelanti di una tradizione, per quanto sia essa gloriosa, geniale o eroica, non ci rende necessariamente gloriosi, né geniali, né eroi. E fa perdere di vista che non tutte le eredità hanno pari dignità, che un progetto da realizzare può restituire altrettanto senso di uno ereditato, che una città nuova può essere più funzionale, bella e sicura di quella in cui si è cresciuti.
Ne «Le Città Invisibili» Italo Calvino scriveva: «(…) È inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati». Come è pesante essere un popolo di «figli di». Riusciremo a dare forma ai nostri desideri?
Anche su Specchio Economico – Novembre 2016















